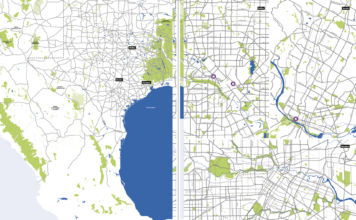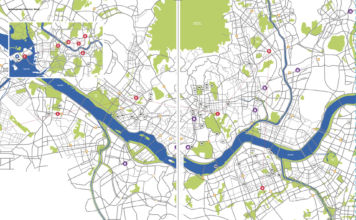Si chiama Atlas il nuovo progetto dello studio No Architects e si trova nel cuore della National Gallery di Praga.
Atlas, o Creative Studio and Laboratory of Associative Dreaming, è soprattutto una bella idea, un lavoro collettivo divertente e aperto...
Il 2024 di Contract District Group ha visto l’apertura di una nuova divisione del gruppo dedicata al “Family Contract” pensata per servire il canale dei professionisti e dei loro clienti.
Già molti sono i progetti in sviluppo tra i quali...
Il progetto di Villa Tarantino, opera di recupero realizzata dallo studio Keller Architettura, si inserisce nel filone del dialogo tra architettura contemporanea e archeologia industriale. Ricco di contaminazioni del Novecento, l'impianto originario dell'edificio è ottocentesco, neoclassico e con muratura...